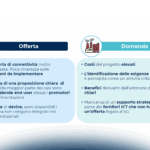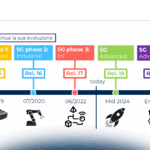Le reti di telecomunicazioni satellitari: la tecnologia, i progetti e gli sviluppi futuri
Il fenomeno delle reti satellitari
Negli ultimi anni le reti satellitari stanno raccogliendo un interesse sempre maggiore dalle aziende, dai Paesi e dai consumatori, grazie alla forte spinta tecnologica e di marketing delle compagnie che producono e lanciano satelliti in orbita per servizi di telecomunicazioni. Tra tutti, l’azienda più famosa e più in risalto, soprattutto in Italia, è l’americana Starlink, ma non è la sola che offre questo tipo di servizi. Infatti, anche compagnie europee, come Eutelsat Oneweb, offrono gli stessi servizi di telecomunicazione satellitare. Sebbene si senta parlare da pochi anni di queste mega costellazioni di satelliti che offrono servizi Internet, le telecomunicazioni satellitari nascono a metà dello scorso secolo.
La prima ideazione di un sistema di telecomunicazioni satellitari fu menzionata da Arthur C. Clarke nel suo articolo scientifico “Extra-Terrestrial Relays” del 1945, dove descrisse per la prima volta l’architettura di un sistema di questo tipo. Il sistema in questione avrebbe avuto lo scopo di far transitare i messaggi da una parte all’altra del globo terrestre, anticipando di 12 anni il lancio del primo satellite per offrire servizi di telecomunicazioni, che fu lo Sputnik lanciato dall’Unione Sovietica nel 1957. Negli anni successivi, fino ai giorni nostri, furono lanciati altri satelliti, anche da compagnie private, per offrire servizi di telecomunicazione e broadcasting televisivo.
Solo negli ultimi anni però, con l’introduzione di nuove tipologie di satelliti, è stato possibile portare l’offerta di servizi Internet a banda larga. Il principale vantaggio di queste costellazioni di satelliti, e per il quale c’è un crescente interesse, è il fatto di riuscire a portare la connessione Internet in zone dove la rete terrestre tradizionale non riesce ad arrivare. Infatti, non essendo vincolato al terreno, ma muovendosi continuamente intorno al globo, un sistema di satelliti è in grado di coprire ampie zone geografiche.
Nel caso dell’Italia, un’ipotesi di cui si sta parlando sarebbe quella di adottare le telecomunicazioni satellitari per completare il piano Italia 1 Giga, dato che ad Agosto 2024 l’avanzamento dei civici connessi era al 28%, e il piano avrebbe scadenza a Giungo 2026. In particolare, le costellazioni di satelliti potrebbero connettere quelle che vengono definite “case sparse”, cioè lontane dai centri abitativi in cui gli operatori di telecomunicazioni hanno le proprie infrastrutture. Queste case in Italia sono circa 500.000, e il costo per stendere cavi in fibra ottica fino a queste abitazioni non è ripagato dagli abbonamenti che queste famiglie dovrebbero sottoscrivere. In questo caso, le telecomunicazioni satellitari rappresentano una possibile alternativa alle reti terrestri per soddisfare la richiesta di connessioni Internet a banda larga per queste zone remote1.
Come funzionano le reti di telecomunicazioni satellitari?
Dal punto di vista architetturale, le reti satellitari si differenziano da quelle terrestri, aggiungendo una componente nel percorso che fanno i dati dalla richiesta dell’utente all’effettivo download sul dispositivo; cioè, il satellite e l’antenna che si collega al satellite stesso. Per capire meglio il funzionamento, è utile fare un esempio del percorso che fanno i dati dopo una richiesta di un utente. Quando, per esempio, un utente accede ad Internet dal proprio dispositivo, quest’ultimo manda una richiesta al router wi-fi installato nella propria abitazione che a sua volta manda la richiesta all’antenna installata o sul tetto o in un luogo aperto fuori dall’abitazione, che manda la richiesta al satellite nello spazio. Dallo spazio, il satellite invia il segnale ad una stazione di Terra, tipicamente un’antenna radio, che a sua volta smista la richiesta ai server dove sono archiviati i dati richiesti dall’utente. Una volta identificati i dati, questi ultimi fanno il percorso inverso per essere visualizzati sullo schermo del dispositivo dell’utente. Può sembrare un percorso molto lungo, ma tutto questo avviene nel giro di decine di millisecondi. Inoltre, se la stazione di Terra non dovesse essere vicina al satellite, e quindi non potesse ricevere il segnale, i satelliti di ultima generazione hanno la possibilità di mandare tra di loro, tramite link ottici, i dati fino ad arrivare al satellite più vicino ad una stazione di Terra, che poi smisterà la richiesta ad un server. Anche se può sembrare la tecnologia più usata per il traffico dati, in realtà non è così: infatti, circa il 97% del traffico Internet globale viaggia attraverso i cavi sottomarini in fibra ottica, ovvero tramite le reti terrestri. Queste, infatti, rimangono le infrastrutture più utilizzate per far transitare i dati Internet, ad evidenziare il fatto che il fenomeno delle reti satellitari per la connessione Internet è un fenomeno abbastanza recente.
Non esiste solo una tipologia di satelliti che offrono servizi di telecomunicazioni, ma le classificazioni sono relative alla distanza dalla Terra, che può essere: in orbita Geostationary-Earth Orbit (GEO), circa 36.000 km dalla Terra, orbita Middle-Earth Orbit (MEO), dai 10.000 ai 20.000 km dalla Terra, e orbita Low-Earth Orbit (LEO), tra i 160 e i 2.000 km dalla Terra. I satelliti in queste diverse orbite hanno prestazioni e caratteristiche diverse, nonché una numerosità diversa per la singola orbita. I satelliti in orbita GEO, per esempio, sono molto grossi e potenti, dato che operano ad un’elevata distanza dalla superficie terrestre, ma hanno il vantaggio della poca numerosità necessaria per coprire tutto il globo. Infatti, bastano tre satelliti per coprirlo. Lo svantaggio principale di queste costellazioni risiede nell’elevata latenza rispetto ad altre tecnologie o tipologie di satelliti, che è di circa 600 ms, e nel basso numero di postazioni disponibili in orbita, dato che sono quasi tutte occupate da satelliti esistenti. L’orbita MEO è, ai giorni d’oggi, quella meno utilizzata e saturata, ma richiede un numero maggiore di satelliti rispetto all’orbita GEO. La maggior parte delle offerte di connessioni Internet tramite reti satellitari che si vedono oggi, invece, è posizionata nell’orbita LEO, come per esempio le offerte di Starlink ed Eutelsat Oneweb. In quest’orbita, i satelliti hanno performance di connessione migliori, dato che la latenza si aggira intorno ai 40 ms, e hanno la caratteristica di essere molto numerosi, portando il concetto di “mega costellazioni” di satelliti. Infatti, la costellazione più grande è posseduta dall’americana Starlink, che ha lanciato in orbita più di 6.000 satelliti, con l’obiettivo di arrivare a 12.000 per garantire una copertura globale totale. Un’altra differenza tra queste varie tipologie di satelliti è relativa alla vita utile e agli investimenti richiesti. Infatti, per un satellite GEO, l’investimento economico è maggiore di un satellite LEO, data soprattutto dalla maggiore potenza richiesta per comunicare con la Terra. Inoltre, ha anche una vita utile maggiore, di 10-15 anni, rispetto ai 4-5 anni di un satellite LEO. Questa differenza risiede nel fatto che questi ultimi richiedono aggiornamenti continui per i servizi che offrono, e quindi non avrebbe senso progettarli per una vita utile più lunga di questa finestra temporale2.
Il confronto con le reti terrestri: quali sono i pro e i contro?
Dal punto di vista delle performance di rete con le quali valutiamo le tecnologie di connettività, sia terrestre che satellitare, oltre alla già citata latenza, è utile fare un paragone con la velocità di download. Infatti, i satelliti LEO moderni garantiscono velocità di download di circa 200 Mbps, mentre in upload, la velocità è di un ordine di grandezza inferiore, cioè di circa 20 Mbps. In aggiunta, queste performance potrebbero diminuire a causa di eventi metereologici come i temporali, dato che devono inviare un segnale a svariati Km di distanza dalla Terra e viceversa. Se paragonati alle reti terrestri, la partita della performance è persa, perché con la rete in fibra ottica attuale si raggiungono stabilmente i 900 Mbps in download e circa 300 Mbps in uplink, con una latenza inferiore ai 40 ms delle reti satellitari. Inoltre, la rete in fibra ottica ha la caratteristica di adattarsi nel futuro ad ulteriori standard di performance cambiando “semplicemente” gli apparati di rete ed arrivando a velocità di circa 40 Gbps. In questo senso, anche l’infrastruttura stessa garantisce maggiore flessibilità per il futuro. A questo vantaggio, si affianca lo svantaggio della difficoltà, come detto in precedenza, nello sviluppo fisico della fibra ottica; cioè, la stesura dei cavi. Infatti, per coprire aree remote è necessario scavare nel terreno per stendere i cavi, che richiedono tempo per i lavori e investimenti che senza incentivi pubblici sono elevati da affrontare per un provider di infrastrutture. Ecco che, le reti satellitari potrebbero garantire una copertura per queste zone difficilmente raggiungibile dalla fibra ottica.
Il diretto competitor delle reti satellitari, però, sono una tipologia di reti terrestri basate su tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). In questo caso il cavo in fibra ottica arriva fino ad un’antenna radio, situata in una posizione strategica, che poi trasmette tramite onde radio ad un modem indoor/outdoor, situato in un’abitazione, che trasmette il segnale ai singoli dispositivi connessi. Con la tecnologia 5G, alcuni operatori di telecomunicazioni terrestri hanno creato offerte sfruttando la tecnologia FWA, grazie soprattutto all’ampio spettro di frequenza disponibile che garantisce di proporre un’offerta alle abitazioni fuori dai centri urbani che non dispongono di banda ultra-larga. In Italia vari operatori si stanno muovendo verso questa direzione, e oltreoceano, in USA, il 5G FWA sta prendendo sempre più piede con un aumento di offerte sottoscritte. Dal punto di vista delle performance, le reti FWA, soprattutto quelle sviluppate con tecnologia 5G, sono paragonabili a quelle delle reti satellitari, incrementando le performance rispetto al passato. Infatti, oltre che per le performance, anche dal punto di vista del segmento clienti sono diretti concorrenti, dato che entrambe si rivolgono ad abitazioni fuori dai centri urbani che non dispongono di collegamenti in fibra ottica3.
Quali sono i progetti per la creazione di costellazioni di satelliti per le telecomunicazioni?
A livello mondiale sono nati vari player con l’obiettivo di offrire servizi di telecomunicazioni tramite infrastrutture satellitari. Tra i più famosi c’è la già citata Starlink di SpaceX, che è l’azienda che investe maggiormente nella tecnologia e con la flotta di satelliti più grandi, più di 6.000 satelliti. Inoltre, ha già 4 milioni di clienti a livello globale, di cui 55.000 in Italia. Sempre sulla sponda americana, un diretto competitor sarà Amazon Kuiper, che progetta di lanciare 3.200 satelliti in orbita LEO per offrire servizi di telecomunicazione a banda larga in tutto il globo. Per ora, però, sono stati lanciati solo due prototipi di satelliti per effettuare test di connessione e gestione orbitale, il che fa pensare a tempi di messa in opera della costellazione ancora lunghi.
In Europa, invece, tra le iniziative attive c’è la costellazione Eutelsat Oneweb, che conta un discreto numero di satelliti, anche se di molto inferiori alla costellazione di Starlink, divisi tra orbita GEO (34 satelliti), per offrire alte performance di throughput, e orbita LEO (più di 600 satelliti), per offrire bassa latenza e copertura globale. L’offerta di Oneweb è molto simile a quella dell’americana Starlink, rendendola l’unica concorrente europea. La differenza tra le due aziende è che nel caso di Starlink viene creata una società in ogni paese nel quale propone la propria offerta, mentre nel caso di Oneweb vengono stabiliti degli accordi con gli operatori nazionali.
A livello europeo, è in fase di sviluppo il progetto IRIS2, che prevede di lanciare in orbita una costellazione di 290 satelliti tra l’orbita LEO e MEO e di renderla operativa nel 2030. L’obiettivo di IRIS2 è quello di creare la prima costellazione di satelliti europea per offrire agli stati membri e ai cittadini connettività avanzata e diminuire il digital divide all’interno dell’Unione. Questo progetto ha l’obiettivo strategico di sostenere l’autonomia e la leadership tecnologica dell’UE. Infatti, grazie a questa costellazione, il traffico dati Internet che transiterà su questa rete sarà sotto il pieno controllo dell’Unione, senza passare per aziende extra europee come Starlink, dato che sopra una certa quota spaziale non esistono più i confini nazionali e quindi viene meno il concetto di sovranità nazionale del dato. Con IRIS², l’Unione Europea vuole consolidare la sua posizione di leader mondiale nella connettività satellitare sicura, garantendo resilienza di fronte alle sfide future e alle future integrazioni con tecnologie mobili come il 6G e altre tecnologie digitali come Cloud computing ed AI. Per progettare questa flotta di satelliti è stato creato un consorzio europeo sotto il nome di SpaceRISE, dove tre aziende leader nel settore spaziale europeo, SES SA, Eutelsat SA, e Hispasat S.A., che costituiscono la parte core di tale consorzio, sono affiancate da un team di partner per lo sviluppo tecnologico quali: Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat, e Thales SIX.
A livello italiano, invece, il player con il maggior numero di satelliti lanciati in orbita è Apogeo Space, con 20 pico satelliti in orbita LEO. Questi ultimi sono satelliti molto piccoli, che pesano tra 0,1 – 1 Kg con dimensioni di 10x10x3 cm, che possono offrire servizi di telecomunicazioni, in questo caso specifico offrono servizi legati al mondo IoT. Questi satelliti, essendo di così piccole dimensioni, non vengono catalogati come costellazione, ma bensì come sciame. La piccola dimensione di questi satelliti è legata al fatto della minor potenza necessaria per trasmettere dati legati all’IoT, come per esempio il monitoraggio dei sensori nel mondo dell’agricoltura o dell’Oil&Gas. Entro il 2027 l’azienda italiana punta a lanciare un centinaio di satelliti per offrire una copertura totale senza interruzioni.
Quali saranno le evoluzioni future di questa tecnologia?
Dal punto vista delle evoluzioni tecnologiche future, le principali direzioni di sviluppo riguardano due temi:
- La connessione direct-to-device, cioè la connessione diretta dal satellite ai dispositivi, come PC e smartphones, senza passare da un’antenna di Terra. Questa sfida è sicuramente la più ardua dato che c’è un’elevata complessità progettuale per garantire connettività ai singoli dispositivi da un satellite che è in continuo movimento intorno al globo e a svariati Km di distanza;
- L’aggiornamento tecnologico dei lanci dei satelliti e soprattutto del loro ritorno sulla superficie terrestre. Infatti, da quando è stato lanciato il primo satellite nel secolo scorso, la tecnologia dei lanci è sempre rimasta la stessa, con un razzo che tramite combustibile porta nell’orbita desiderata il satellite. L’unico aggiornamento è stato relativo al fatto di far ritornare i razzi per riutilizzarli per lanci successivi. Dal punto di vista del ritorno sulla superficie del singolo satellite, invece, la soluzione più utilizzata è la disintegrazione dei satelliti con l’impatto con l’atmosfera terrestre, che produce però ossido di alluminio, che è una sostanza molto pericolosa per lo strato di ozono che ci protegge dalle radiazioni solari. Questo aspetto risulta cruciale per il futuro, portando l’attenzione e l’innovazione tecnologica verso la promozione della sostenibilità ambientale per il Pianeta e per questo settore. Infatti, si stanno studiando dei sistemi per far rientrare i satelliti giunti a fine vita sulla Terra senza lasciarli nello spazio come detriti o facendoli disintegrare all’impatto con l’atmosfera4.
Nel complesso, le reti satellitari rappresentano un fenomeno in forte espansione e un settore tecnologico in pieno sviluppo. Questa evoluzione può portare vantaggi concreti sia alle imprese sia ai cittadini, in particolare a coloro che vivono in aree periferiche o rurali, spesso escluse dalle infrastrutture di rete tradizionali. In questi contesti, le reti satellitari si presentano come uno strumento promettente per ridurre il divario digitale e favorire una maggiore inclusione tecnologica. Tuttavia, allo stato attuale, le prestazioni offerte da queste reti non sono ancora paragonabili a quelle delle reti terrestri, soprattutto in termini di velocità e stabilità della connessione. Nonostante ciò, numerosi progetti sono già in corso e molte aziende stanno investendo in modo significativo per migliorare l’efficienza e la copertura di questa tecnologia. Guardando al futuro, si prevede un utilizzo sempre più diffuso e integrato delle reti, sia satellitari che terrestri, in una logica complementare. L’obiettivo sarà quello di costruire un’infrastruttura di rete globale, capace di offrire connessioni affidabili, veloci e capillari in ogni angolo del pianeta.
1 https://www.spreaker.com/episode/starlink-per-il-piano-italia-a-1-giga-con-stefano-bolis–62733973
4 https://www.youtube.com/watch?v=HmzVySZ9O3g&list=PL4IIL-J6FcrjM88L-frk_fmL0ig0VNKD_&index=45
A cura di

Luca Dozio
DirettoreDirettore Osservatorio 5G & Connected Digital Industry e Ricercatore Senior Osservatorio Cloud Transformation.Ha conseguito la laurea in Ingegneria Gestionale con una specializzazione in Supply Chain Management nel settembre 2015. Da allora lavora presso gli Osservatori Digital Innovation svolgendo attività di ricerca e progetti sui temi dell’innovazione digitale, con focus su Cloud Transformation e reti 5G. Nel 2019 ha completato un Percorso Executive in Gestione Strategica dell’Innovazione Digitale.

Edoardo Meraviglia
RicercatoreRicercatore dell'Osservatorio 5G & Connected Digital Industry
Siamo a tua disposizione per informazioni e assistenza

Martina Vertemati
Acquisti e abbonamenti Da Lunedì al Venerdì, dalle 09 alle 18
Alessia Barone
Assistenza Da Lunedì al Venerdì, dalle 09 alle 18Scopri altri contenuti di 5G & Connected Digital Industry